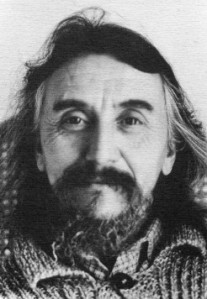(ovvero accadde negli anni ’60)
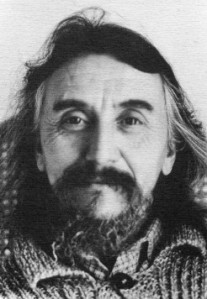
Paranoia:
Termine molto diffuso in tempi, e tra tribù, che paiono oggi sogni di nuvole. Indicava l’atteggiamento aggressivo o difensivo di molti inquilini della Terra. ‘Andare in paranoia’ era l’opposto dell’ ‘andare in samadhi’. La cravatta che premeva sul gozzo era l’opposto dei corpi nudi sui prati. La disciplina era il flagello che obbligava maschi e femmine a stare eretti: mi spezzo ma non mi piego. A volte una fumata gestita male poteva mandare qualcuno in paranoia: nemici dappertutto, terrore ed angoscia dilatavano le pupille. Ma c’era sempre una guida, uno che non fumava, a ricondurre il malcapitato da un volo sgangherato al calore del gruppo. Il bisogno di successo e di dominio erano cause di paranoia. Quelli così rigidi si aiutavano sovente con prodotti chimici, le famose ‘pasticche’ di cui parla Guccini in ‘Dio è morto’: amfetamine per accelerare e superare: cazzate!
Paria :
Casta di intoccabili in India. Nella Svizzera del cioccolato e delle banche fu invece il nome dell’ultima rivista capelluta in lingua italiana. La pensò, la amò e la produsse, assieme ad elfi cosmopoliti, Antonio Rodriguez Pariananda. Il ritorno della cultura del piombo avvelenò l’aria ed anche quei fogli coloratissimi, scritti a mano, gioco-libertà, non poterono più respirare e sparirono in attesa che nuovi Mago Merlino possano ridare voce alle Voci.
Pellegrino:
Così dice Tukaram: “Cammina verso Pandhari, cammina,/ fatti pellegrino, fatti”. Dice Deleury: “Tukaram fu un grande pellegrino tanto che il gruppo religioso che egli fondò fu chiamato dei ‘Pellegrini’. Uno dei termini più impiegati in India per indicare un gruppo religioso è Panth, che significa via, strada: fanno parte della medesima strada coloro che seguono il medesimo cammino verso la liberazione. L’uomo comune chiama i pellegrini col nome di ‘inghirlandati’: si riconosce, infatti, il Pellegrino dai grani di basilico con cui si adorna”. (Psaumes du pèlerin – ed. Gallimard, 1956)
Pianeta :
Quello che noi auspicavamo era un Pianeta organico, pacificato al modo del ‘Cantico delle Creature’ di Francesco d’Assisi. A Milano nacque nel 1968 un Pianeta tutto particolare, il ‘Pianeta fresco’, a cura di Fernanda Pivano ed Allen Ginsberg con il contributo di Ettore Sottsass e di tutti i viandanti che passarono dalla casa di Nanda. Ne uscirono due numeri, distribuiti a mano da dolci e bionde naiadi. Vi pubblicai un saggio sul Buddismo Mahayana. La rivista, psichedelica e difficile, rimase un prodotto ineguagliato nel panorama delle pubblicazioni non ufficiali e autorizzate. I fogli underground erano cavalli selvaggi: difficili da addomesticare ma con vita estremamente breve. Eccezione fu Stampa Alternativa che pur non provenendo dalle Tribù ospitò le voci le più disparate, disperate e profetiche.
Pistoletto:
Pittore e curatore di giardini psichedelici. A Torino aprì la sua arte, la sua casa e la sua amicizia, con la sua compagna Maria, alla nomade psichedelìa di strada. Nacque lo Zoo, gruppo fantastico, amorevole e creativo, che produsse per alcuni anni performances che segnarono il panorama artistico del tempo. Collaborai con Michelangelo e Maria per un certo periodo. In alcuni casi insufflai un po’ dello spirito tribale. Ricordo, in particolare, la performance ‘L’Uomo ammestrato’ a Vernazza nel 1968, mentre a Praga i carri armati sovietici, guidati da mongoli perché non vi fosse possibilità di dialogo, presidiavano piazza Venceslao. Nel lavoro si raccontava, appunto, il rifiuto di farsi ammaestrare e le amare conseguenze, quando questo avveniva. In piazza, con giro del cappello. Soggettivamente era il tentativo di portare avanti un’azione in contesti per me inconsueti. Pistoletto dirà e scriverà che quell’operare gli ricordava più la tribù che l’arte.
Pitecantropus:
Il ‘Pitecantropo eretto’: l’ultimo verso-urlo d’un mio poemetto del tempo della soffitta. Divenne il nome della prima casa editrice underground in Italia. Vi pubblicarono sette poeti con nove volumetti. Ebbe l’onore d’essere denunciata nell’autunno del 1967 e di essere processata. Furono assolti i quattro poeti in tribunale, incriminati per scritti contrari alla pubblica decenza.
Pivano:
Ovvero Nanda. Per me fu Ananda Nanda, grande gioia. Ci fece conoscere la scena beat americana. Ci accolse nella sua casa. Ci avvolse nelle sue premure. Molti dei protagonisti del tempo devono riconoscenza a Nanda. Con Allen Ginsberg produsse ‘Pianeta Fresco’. La casa a Milano di Nanda fu un ritaglio di pace nel grande kaos del tempo. Ma era ancora nulla. Attentati, anni di piombo, leggi speciali, confermarono quanto avessimo ragione, profeticamente, noi e Nanda nell’essere pacifisti e non-violenti, offrendo la nostra nudità come unica ricchezza.
Povertà:
Che è quella cosa per cui vai a comprarti vestiti di seconda mano al Balôn di Torino, in un negozio dove vendono abiti militari, robusti ed indistruttibili, compresi i sacchi-a-pelo in dotazione all’esercito americano: in culo all’Esercito! Ed anche quella cosa per cui non sai dove andare a dormire e di certo dormi d’estate sulle panchine quando sei fuori dalla tua città e mangi quando hai i soldi che magari, come succedeva in piazza Duomo a Milano, ottieni con la questua. Povertà come stato. Ma anche povertà come rifiuto del superfluo e della proprietà, come valore e come scelta. La denutrizione conseguente lavorò sulle gengive, sanguinanti come Dracula in trasferta. A Parigi, nel 1966, si mangiavano baguettes, svuotate della mollica per usarle come recipienti, e fagioli in scatola. Ad Amsterdam mangiai per poco in un ristorante cinese: montagne di riso. Fu facile, quindi, lo sciopero della fame nel giugno 1966 ed utile il non andare dal parrucchiere. Quando fui denunciato per la pubblicazione di ‘Guru’ con la Pitecantropus ebbi due avvocati (correva l’autunno 1967 e nell’agosto dello stesso anno Allen Ginsberg era stato denunciato, e poi assolto, per scritti osceni, a Spoleto, al Festival dei Due Mondi). Non avevo di che pagarli. Mi risulta che pittori amici intervennero con loro opere. Grazie.
Presidente:
Per antonomasia è il(i) Presidente(i) degli U.S.A. Nella storia recente ricordiamo Kennedy, Johnson, Nixon. Il primo lanciò la parola d’ordine della ‘nuova frontiera’, aprendo la prospettiva a grande speranze. Fu ammazzato. Il secondo è ricordato in rapporto al Viet-nam sul quale scaricò napalm e defoglianti. Il terzo, ex-attore hollywodiano, per un ritorno dell’Amerika a sistemi che si pensavano superati. Sparì dalla scena politica per una questione di fondi illeciti. Al nome di Nixon venne mutata la grafìa. Al posto della ‘x’ si sostituì la svastica.
Provos:
Ílare tribù di folletti bianchi olandesi. Nati in un contesto strettamente amsterdamiano contro la malevolenza e l’assurdità del sistema occidentale proposero e vissero la provocazione per smontare la presunta razionalità sociale, le biciclette bianche furono farfalline amorose lungo i canali di Amsterdam, per ridare fiato al Pianeta l’occupazione creativa di case vuote evitarono che la città assomigliasse sempre più a un teschio con orbite prive di vista. Incontrai attivamente i Provos nel 1966 a Parigi e poi nell’inverno a Milano ad un congresso anarchico.
Psiconauta:
Viaggiatore dell’anima: Ve ne furono tanti e di tanti indirizzi. Alcuni andarono in oriente a cercare un luogo dove l’anima respirasse più liberamente, altri andarono in alto sulle montagne, altri penetrarono in mandala di comunicazione, altri ancora cercarono nel cerchio magico delle tribù il filo dell’anima perduta.
Pubblicazioni :
Tante, precarie, clandestine, fatte a mano, ciclostilate, eliografate (come Tampax, foglio kilometrico eliografato pensato e composto da Giulio Tedeschi nei primi anni ’70). Una legge assurda ed obsoleta pretendeva che una pubblicazione dovesse avere obbligatoriamente un direttore responsabile iscritto all’albo dei giornalisti!!! Alla faccia della libertà di stampa e di espressione! Persino i volantini dovevano portare in calce l’indicazione dello stampatore. Nonostante la censura ed i sequestri, anche in Italia vi fu un grande pullulare di fogli, la cui vita, di solito, non superava i tre numeri. Siccome per un ‘numero unico’ non v’era l’obbligo della registrazione, si superava l’ostacolo cambiando per ogni numero l’intitolazione. Il boss di ‘Stampa Alternativa’, Marcello Baraghini, giornalista, prestò il suo nome a molte pubblicazioni underground. Grazie. Per il resto bella democrazia!, in nome della quale si castrava il canto e l’espressione.
Santo:
Ovvero l’Holy holy holy di Ginsberg. Il termine ‘santo’ si applica a tutto ciò che è, creato, creatura, creatore perché riposano tutti nel dolore e la consapevolezza li purifica. Santa è la vita e santa è la morte. Raccontava Fernanda Pivano che Allen Ginsberg alla fine di una sua lettura di ‘Kaddish’ in una chiesa battista in America scese dal pulpito e toccando tutto ciò che trovava, cose, uomini e donne, continuò a salmodiare Santo Santo Santo. Con questo significato ‘I Nuovi Santi’: mio poemetto, causa di un processo.
Sesso:
Nell’immaginario cattolico-borghese una realtà che ‘purtroppo’ c’è e porta verso l’inferno. Lo si può esorcizzare, il sesso, facendo dei figli. Certo bisogna fare all’amore, certo c’è piacere ed orgasmo, certo ci sono liquidi seminali…
Maria, madre di Gesù, non ebbe bisogno di tutto ciò per fare un figlio. Verginità della donna come supremo valore. Gli uomini, invece, al casino. Il sesso enfatizzato e ingigantito. Tutti i falli erano enormi e li si misurava a spanne. Le vagine, invece, almeno a leggere i graffiti sui cessi maschili, erano orizzontali come bocche. Nessuno aveva letto ‘I gioielli indiscreti’ di Diderot. Nessuno rideva. Ci si prendeva enormemente sul serio. La masturbazione faceva diventare ciechi ed era meglio al buio completo fare all’amore, quando lo si faceva! Le cabine in spiaggia avevano il foro del voyeur e solo Brigitte Bardot sembrava allegramente dichiarare che essere sessuati è bello (ma i suoi film erano vietati ai minori). La censura tagliava, tagliava. I sessi cadevano, cadevano. Ciò che fece scattare la denuncia ed il processo per ‘Guru’ fu l’uso di parole indicanti parti sessuali o affini. Eppure i bambini continuarono a venire al mondo, non sotto al cavolo, non portati dalla cicogna. Misteri della cultura italiana negli anni sessanta!
Tribù:
Agglomerazione umana che si proponeva come alternativa allo stato anonimo ed oppressivo. La tribù era formata da persone che liberamente si sceglievano avendo passati e speranze in comune. Molto influì la storia dei Nativi Americani. Nelle tribù, agli inizi c’era un leader ( a Torino, nel 1965, ve n’era uno che chiamavano Gesù e portava una lunga, fluente, parrucca rossa). In seguito il leader sparì e rimase soltanto il bardo, il poeta-sciamano. Da noi scattavano ricordi indigeni, quelli dei Celti, popolo malinconico che amava la natura, amava raccontare, amava la poesia.
Visione:
Intuizione colorata, dono, adesione alla non-divisione, superamento dell’Io parcellizzato e parcellizzatore. Le grandi visioni non ci indicano una meta ma che siamo da sempre giunti. Ci dicono che il nostro destino è ‘essere’. Quando ‘sentiamo’ fortemente la visione, allora, come dicono i maestri zen, “il vecchio uomo torna a casa”. Stimoli a percepire visioni furono immagini, erbe, pratiche, letture, incontri, devozioni, che misero in crisi la struttura rigida e difensiva del nostro Io, armato di civiltà e di pregiudizi.
a cura di Gianni Milano